The Reef & The Craft
Ero una piccola creatura nel cuore
Prima di incontrarti,
Niente entrava e usciva facilmente da me;
Eppure quando hai pronunciato il mio nome
Sono stata liberata, come il mondo.
Non ho mai provato una così grande paura, perché ero senza limiti.
Quando avevo conosciuto solo mura e sussurri.
Stupidamente sono scappata da te;
Ho cercato in ogni angolo un riparo.
Mi sono nascosta in un bocciolo, ed è fiorito.
Mi sono nascosta in una nuvola, e ha piovuto.
Mi sono nascosta in un uomo, ed è morto.
Restituendomi
Al tuo abbraccio.
Mary-Elizabeth Bowen
ABITO CERIMONIALE
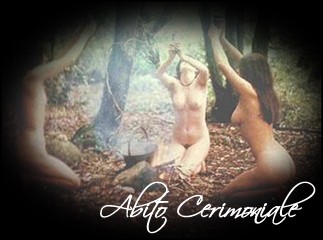
STORIA
L'abito cerimoniale non è propriamente uno strumento, ma molti praticanti lo ritengono una cosa fondamentale. La vestizione ha radici antiche in qualsiasi cultura, e trova simbolismo in tutte le tradizioni, soprattutto nelle vestizioni di tipo religioso. Una divisa, un abito, da sempre distingue la classe sociale e il ruolo delle persone che lo indossano.
Nella wicca, la veste cerimoniale ha un valore molto soggettivo. Diversamente da altre culture come il cristianesimo, dove invece l'abito talare ha un ruolo determinante che prende peso soprattutto come distinzione tra le varie gerarchie clericali, come colore e forma, nella wicca tradizionale questo luogo comune non trova spazio, in quanto nella tradizione gardneriana era imposta la nudità rituale.
Ad oggi queste imposizioni non sono più così radicate in quanto la wicca si è diramata in varie tradizioni differenti con ognuna la sua ritualità diversa.
In molte culture troviamo il travestimento come "trasformazione", quindi strettamente legato al lato iniziatico. L'abito riveste qui l'aspetto di metamorfosi in qualcosa di diverso. L'abbandono delle spoglie mortali per entrare nel cerchio a cospetto delle divinità.
Alcune culture ritengono il cappuccio che copre la testa fondamentale. Soprattutto quelle che credono nell'uomo-dio. La vestizione prende così significato nell'abbandono della natura mortale e l'avvicinamento a quella divina, quanto meno durante il rituale, e il cappuccio (al contrario di quanto si potrebbe facilmente pensare) non andrebbe a "nascondere" l'identità di chi partecipa al rito dagli altri partecipanti, bensì un modo per accentuare l'idea che gli dei siano privi di volto.
Nella wicca questo non ha peso alcuno. La nostra comunione con gli dei avviene a viso aperto e senza bisogno di coprirci. Rimane comunque valido il discorso della vestizione come "muta" per avvicinarci al rituale, agli dei. L'estetica in questo non ha alcun peso. Prende importanza il simbolismo di questa stessa estetica invece; il colore soprattutto, o gli eventuali disegni sopra riprodotti.
Anche l'abito da sposa è un abito rituale che nel corso del tempo nella religione cattolica è rimasto ancorato ad alcuni vecchi simbolismi; lo stesso colore: il bianco, riporta la purezza dello spirito santo (che si manifesta e si rappresenta come una colomba), e ricorda a chi si accinge al rito del matrimonio che sarebbe necessario essere illibate prima di quel sacro momento. Un tempo l'abito da sposa era invece di colori diversi, ma il bianco era escluso. Si ricercavano colori che riportassero fertilità e non purezza (è anche per questo motivo che si getta il riso innanzi alla chiesa. Gettare semi è l'antico gesto di semina e di abbondanza). Secondo le antiche usanze la sposa dovrebbe seguire una ritualità precisa per propiziare un matrimonio felice e fertile. Dovrebbe infatti seguire la regola di indossare qualcosa di vecchio a rappresentare la famiglia (di solito un cammeo o a volte lo stesso abito nuziale della mamma o l'anello di fidanzamento), qualcosa di nuovo che rappresenti quindi la vita che si va a vivere (le scarpe di solito o qualcosa di intimo), qualcosa che è stato dato in prestito da una sposa precedente e che ha avuto un matrimonio felice (un'amica o una parente) che porterà automaticamente gioia e felicità e in ultimo qualcosa di colore blu azzurro. Questo colore rappresenta la fedeltà.
Vediamo qui come i colori prendono un aspetto fondamentale nell'abito rituale, come anche la stessa "vestizione" della sposa o del sacerdote o del Re, che prima di mettersi dinanzi ai suoi sudditi doveva indossare gli abiti regali che lo riconoscessero per il rango che rivestiva.
Una simile ritualità la troviamo anche nello sciamanesimo o nei culti tribali e totemici e dell'animismo. In Africa ad esempio, in alcune tribù si svolgono riti iniziatici di "abbandono" della forma umana in favore di una forma animale, i quali hanno poi portato alle credenze relative alla licantropia, che nell'antica Roma era nota come "versipellis", letteralmente "pelle rivoltata". Una simile cerimonia la troviamo anche in alcune tribù animiste dei Nativi americani come i guerrieri "Stirpe di Lupo" o anche nella cultura Azteca nei ruoli dei guerrieri d'elite ritenuti nobili come i "Guerrieri dell'Aquila" e i "Guerrieri del Giaguaro" e anche gli "Sciamani del Coyote" che indossavano piume e pelli degli animali dei quali onoravano le gesta. In tutto questo troviamo come l'abito rivesta un ruolo fondamentale nel riconoscere un ruolo o un rango di chi lo indossa.
Il colore ha, come abbiamo visto, un aspetto fondamentale nell'abito rituale. Il viola ad esempio rappresenta la spiritualità e infatti è un tema ricorrente anche nel cristianesimo nella stola del diacono, ma è presente anche il bianco, il rosso, il blu e il nero.
Nella ritualità pagana fondamentale è il ruolo che ricopre il colore dell'abito. Il simbolismo che richiama percorre come un filo ogni cultura. Il nero, ad esempio è un colore riferito alla terra e ai riti di abiurazione; il marrone e il verde ai riti che richiamano fertilità; il rosso, il giallo e l'arancio, ai riti di origine solare, alla rinascita; l'abito bianco invece a quelli di culti lunari.
COS'È?
Sostanzialmente, a parte il simbolismo la veste dovrebbe essere una sorta di tunica, sotto il quale non bisognerebbe indossare niente. Per molti è fondamentale rimanere a piedi nudi durante i riti, affinché ci sia il contatto con la terra. Molti indossano anche il cordone, legato in vita, intrecciato di colori diversi. Alcuni usano semplicemente un mantello, alcuni un vero e proprio abito, altri una semplice tunica di lino o cotone bianco. In vendita ce ne sono di ogni tipo e diverse streghe vestono in maniera differente a seconda della festività, senza necessariamente indossare abiti rituali particolari, ma comunque affini all'elemento o al sabba in corso. Il colore stesso dei vestiti serve quindi da "allineamento" con le energie che scorrono in quel momento e che devono essere invocate.
Diffusa, come abbiamo visto soprattutto nella tradizione gardneriana (nel quale era pressoché imposta), c'è la cultura di "vestirsi di cielo", o anche nominato "skyclad" nelle culture anglosassoni. Questa cultura prevede la nudità rituale, nei luoghi ove, ovviamente, questa è permessa senza incorrere in sanzioni di tipo pubblico. Questo tipo di vestizione spoglia letteralmente il corpo da ogni tipo di compromesso e permette il ritorno al principio della vita, al modo in cui tutti noi siamo venuti al mondo. Molti sono i riti in cui questo tipo di nudità è richiesta o necessaria; superati le prime repulsioni di moralità e pudore, ci si allinea in pochissimo tempo con il ciclo terrestre e ci si sente subito a proprio agio.
COME SI COSTRUISCE?
L'importanza dell'abito rituale sta soprattutto nella sua creazione. Andrebbe cucito a mano, con tessuti più vicini alla natura possibile (lino, lana, iuta, cotone) e colorato con colori naturali. Lo stesso uso dell'ago, della cruna e del filo hanno intrinsechi simbolismi magici e sessuali e legando l'abito al "ragno", quindi il destino, ossia la creazione e la tessitura e quindi alle divinità lunari come Neth, la divinità egizia che aveva tessuto il mondo o anche alle tre Parche, le divinità greche Cloto (che in antico greco significa "Io tesso"), Lachesi (che significa "Destino") e Atropo (che significa "Inevitabile") le quali avevano rispettivamente il compito di filare, intrecciare e tagliare i fili della vita delle persone. La questione del "filare" è ripresa anche in alcuni libri. Racconta la Bradley in "Le Nebbie di Avalon" che l'uso del fuso nel medioevo era talmente monotono che provocava visioni a chi aveva il dono. Igraine, la madre di Gwydion (Artù) profetizzava con la seconda vista quando usava il fuso. Questo anche perché la tessitura dell'abito lo rende zuppo dell'intenzione che si ha quando lo si cuce.
Un particolare occhio di riguardo va, oltre che al tessuto, al colore che si desidera scegliere. La presenza o meno di un cappuccio è irrilevante.
